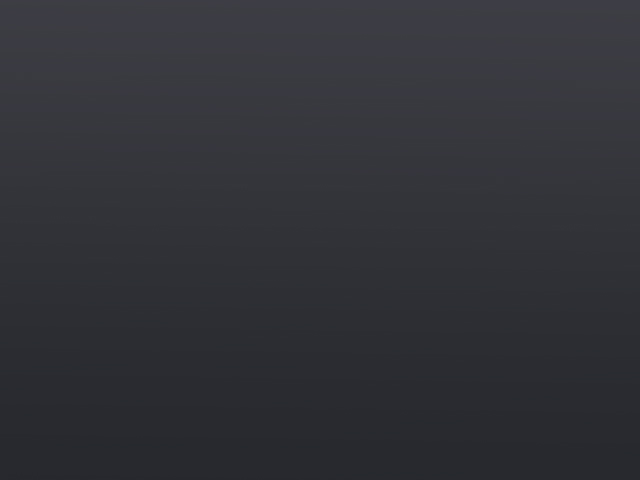Durante il fine settimana le abitazioni dei nostri paesi si popolavano di comitive di amici e parenti per giocare a tombola o a carte. Si trasformavano in vere e proprie sale da gioco. Fra i compagni c’era anche il focolare, dove si dovevano cuocere le castagne, le noci o scaldare qualche altra prelibatezza che i vari amici avevano portato. Si giocava, prima di tutto, per farsi compagnia a vicenda, «così ci prepariamo al Natale» dicevano gli adulti.
Le abitazioni sembravano delle «officine», dove ogni gruppo faceva qualcosa e, qualche volta, interagiva con l’altro gruppo. Le stanze dove ci si riuniva erano grandi, comprese le cucine, i veri centri di queste officine di donne, uomini e tanti bambini. I più piccoli, a seconda del caso, imparavano guardando giocare, come nel caso delle carte, o imitavano e cercavano di riempire le cartelle con qualche legume di fortuna che non era andato nel vaso di creta del focolare.
Poi c’era la «macchina organizzativa», composta per lo più dalle mamme, che sfruttava ogni spunto della discussione per dire come e con cosa si sarebbe cucinato quel piatto o fatto quel dolce «durante le feste»: una vera gara nell’arte della cucina, quella vera, lenta, che si costruiva partendo dalle prime ore del mattino.
Era tutto un prepararsi e un vivere a un ritmo che possiamo solo ricordare. Il «tempo», probabilmente, era ancora più prezioso di oggi, perché non si usava misurarlo in denaro. Niente affatto. A posteriori, oserei dire che il tempo era l’ingrediente a cui si dava maggiore importanza. Ogni attimo era pieno di racconti che scatenavano ricordi nel narratore e emozioni in chi ascoltava.
E così quella domenica, fra le varie programmazioni natalizie, si decise, ad un certo punto del pomeriggio, che i papà avrebbero giocato a tressette nella grande cucina di Stefano, situata al primo piano dell’abitazione con il piccolo giardino prospiciente la chiesa del santo patrono, Elia il Profeta. Ero l’unico ragazzino (bambino, visti i 7 anni) che voleva stare ad ogni costo vicino al suo papà. Volevo imparare ad ogni costo. In realtà al costo del silenzio, l’unico prezzo che si deve pagare quando si vuole imparare per davvero. Mi immaginavo, da lì a qualche anno, giocare a tressette con mio padre e i suoi amici, come faceva mio fratello più grande di me di otto anni. Ogni tanto lasciavo il tavolo da gioco solo per affacciarmi dal balcone che guardava alla chiesa. C’erano le luci che partivano dalla chiesa e riempivano tutta la strada che portava fino alla piazza. Il sindaco, da buon comunista, sapeva meglio di ogni altro che quelle non dovevano mai mancare.
Quando era ormai buio inoltrato, alla porta della cucina si affacciò la nuora del padrone di casa: «gradite delle castagne? Appena calde tirate fuori dalle braci». Dal tavolo della cucina, trasformatosi in quello di una bisca da tressette, si alzò uno sguardo dalle carte che, dopo avere scrutato rapidamente i giocatori, con voce convinta e orgogliosa di avere il nulla osta di tutti esclamò: «basta solo un caffè se non è di troppo disturbo», con tutta la delicatezza che si usava nell’esprimere un desiderio. La signora si avviò per il lungo corridoio che alla fine portava alla finestra prospiciente la chiesa e la si sentì scendere rapidamente le scale.
Ecco, il fumo, quello non era delle castagne, ma della sigaretta che a turno qualche giocatore più ansioso doveva accendere perché il compagno di turno non aveva giocato la carta giusta.
All’improvviso uno scoppio, fortissimo, e tutto cominciò a tremare intorno a noi.
Oggi direi che avemmo la sensazione di saltare sulle sedie, ma probabilmente non si trattò solo di una sensazione. Le prima urla furono del genero del padrone di casa, se non ricordo male Pasquale: «la bombola del gas, è scoppiata». Passarono alcuni secondi, non so quanti, ma a me sembrarono tanti. Credo che Stefano, «il più anziano in servizio», come lo avevano soprannominato i suoi compagni di gioco, esclamò: «no, è il terremoto!». Sentì e vidi mio padre afferrarmi per mano, con forza. Da quel momento quella mano ha tenuto sempre stretta la mia.
Stefano si mise in fondo al corridoio, fra quel balcone da cui mi affacciavo e la porta che mandava sulle scale. «Smistò» tutti noi facendoci scendere per le scale. Da buon padrone di casa, abbandonò la nave solo dopo che tutti i passeggeri andarono via. L’indomani ci informò che alla fine, dopo averci fatto andare via tutti, vedendosi solo, provò a scendere dal balcone. Ci accorgemmo del gesto disperato guardando il gran bernoccolo che aveva sulla fronte; per fortuna nulla di grave.
Dalla casa di Stefano alla nostra, che era nel centro del paese, credo che c’erano da percorrere alcune centinaia di metri. Due cose ricordo perfettamente: le donne che correvano verso la chiesa per inginocchiarsi davanti al santo che probabilmente tante volte avevano invocato in loro aiuto e quella mano che non mi ha mai lasciato salvo un paio di volte, quando vedendomi inciampare durante la corsa, la lasciava per prendermi sotto braccia. In realtà c’è un altro dettaglio vivido nei miei ricordi: il tremore della terra e la caduta delle pietre intanto che attraversavamo le vecchie strade del paese.
Finalmente arrivammo davanti casa. Tutte le amiche e gli amici dei miei fratelli e di mia mamma erano corsi vie, per raggiungere le proprie famiglie. Vidi mia mamma, mio fratello e le mie sorelle, una delle quali più piccole di me, li davanti alla porta di casa. Ci fu un battibecco rapidissimo fra mamma e papà sul da farsi. L’una, forse colta da una sorta di incantesimo dovuto allo spavento, suggeriva di rientrare in casa, l’altro di andare subito via perché potevano ritornare le scosse. Pochi secondi per decidere e poi tutti e sei in macchina.
Intanto, da quello scoppio a casa di Stefano, erano passati solo pochi minuti, credo tre o quattro. Solo dopo ho saputo che la durata di quel «tremore della terra» era durato 90 secondi. A me sembrò un tempo lunghissimo. Mi spiegarono, poi, che fu uno dei terremoti più devastanti anche per la sua durata oltre che per la sua intensità.
Le luci a intermittenza accompagnavano i pianti disperati (dico oggi) delle persone. Mio padre aveva insistito per andare via e trovare un luogo senza edifici o pali della luce nelle vicinanze. Ci spiegò che erano pericolosi, perché in caso di altre scosse potevano cadere. Ci disse che tutti avrebbero fatto ciò perché era la cosa da farsi.
Ci avvicinammo nel luogo dove stavano costruendo lo stadio. Un piazzale ampio, dove trovarono posto, credo, diverse decine di auto. I miei genitori scesero dall’auto, così come tanti altri. Sentivamo parlare di coperte, giacche e altre cose da usare per coprirci durante la notte. Si, perché da quella prima notte imparammo ad arrangiarci. Avremmo avuto centinaia e centinaia di «scosse di assestamento», gli «sciami sismici» come poi ci insegnarono a scuola. Presto imparammo a convivere con il nostro nuovo «compagno di gioco». A noi più piccini furono impartite poche e semplici istruzioni, del tipo «dovete stare attenti per i prossimi giorni», «state sempre vicini a una persona adulta», «se c’è una scossa e siete a scuola o casa stare sotto il banco o sotto un tavolo o l’arco della porta» e così via.
Passarono un paio di giorni e ricordo mia mamma che ci disse «il Presidente ha chiesto aiuto a tutti gli italiani per il terremoto in Irpinia». Capirò, poi, che si trattava di Sandro Pertini «il Presidente partigiano», che in un discorso alla nazione aveva esortato «gli italiani a mobilitarsi per andare in aiuto ai loro fratelli colpiti da questa sciagura». «Fratelli», il presidente partigiano aveva usato proprio questa parola rivolgendosi ai suoi concittadini. Il discorso del Presidente, oltre a mobilitare l’intero Paese, causò le dimissioni dell’allora Ministro degli Interni e l’immediata rimozione del prefetto di Avellino. E la solidarietà alla povera Irpinia arrivò da tutta Italia e non solo.
Intanto passarono alcuni mesi. Chi poteva, se l’abitazione lo permetteva, dopo un sopralluogo dei tecnici, poteva ritornare in casa, usando sempre tutte le precauzioni del caso. Quegli «sciami» sembravano entrati a far parte della nostra vita. Giorno dopo giorno giungevano notizie sulle vittime che c’erano state in Alta Irpinia e nella stessa città capoluogo, Avellino. I nomi dei paesi che erano nominati più spesso dagli adulti erano Sant’Angelo dei Lombardi, Conza, Lioni, Teora e così via. A scuola ci avrebbero fatto imparare a memoria le cifre di quella sciagura: quasi 3 mila vittime, 9 mila feriti e quasi 300 mila persone sfollate.
Trascorsero poco più di due mesi. La situazione sembrava più calma. Ho un vago ricordo di ritorno alla «normalità» legato al rientro parziale a scuola.
Intanto eravamo arrivati a una domenica di febbraio, precisamente il 14. C’era il matrimonio di una figlia di amici di famiglia e mio padre vi partecipò. Sempre di sera, davanti al focolare, a chiacchierare con fratelli, cugini e amici, «reduci» di una tombolata nella solita bisca casalinga, insieme a diverse compagne di classe di mia sorella che, dopo mesi, finalmente riuscivano a vedersi. All’improvviso di nuovo quel boato e la terra di nuovo che tremava come quella domenica di novembre. Era di nuovo lui, il terremoto, ormai un pò tutti avevamo imparato sul suo modo di entrare in scena. Questa volta a prendere sotto braccia me e mia sorella più piccola fu un cugino, Costantino, che, per sua fortuna, non era presente durante il sisma di novembre. La piazza si mobilitò per mettere al sicuro su un pullman le amiche di mia sorella, in modo che potessero ritornare dalle loro famiglie.
Mio fratello, non ancora sedicenne, prese l’auto di mio padre che guidò con la stessa destrezza di chi lo fa da una vita. Salimmo in auto e andammo di nuovo alla ricerca di una piazza ampia dove non ci fossero né edifici né cose che potessero cadere dall’alto, come da manuale. Ricordo gli occhi preoccupati di mia mamma. Cercò di rassicurarci, come fa ancora oggi, dicendoci «andrà tutto bene». Comprese la nostra paura e la preoccupazione perché non vedevamo ritornare nostro padre. Aspettammo qualche ora.
I fiocchi di neve erano merce rara in quella parte dell’Irpinia, più tendente a un clima partenopeo, ma quella sera il cielo, probabilmente, non volle farci mancare la gioia, oltre a un pò di freddo. Dopo alcuni minuti dall’inizio della nevicata vedemmo avvicinarsi nostro padre. Guardò mamma e le disse «hai avuto paura»? Lei rispose di no, che ci era andata bene. Poi ci abbracciammo e vidi gli occhi lucidi dei miei genitori.
Dopo qualche giorno ricominciarono i problemi che avevamo avuto a novembre, a cominciare dagli approvvigionamenti alimentari e la mancanza di casette mobili che servivano per il nuovo sfollamento. Ricordo una telefonata di mio padre a un suo amico di Avellino. Gli disse che bisognava fare qualcosa perché le famiglie erano per strada. Poi, dopo qualche parola, scoppiò in lacrime. Era la prima volta che lo vidi piangere.
Novembre 2020. Sono trascorsi 40 anni da quella domenica del 23 novembre e quei mesi così intensi riaffiorano più che mai nella mia memoria. Posso solo sentire al telefono i miei genitori che ora sono sulla soglia degli 80 anni e con tanti acciacchi dovuti all’età e non solo. Raramente riusciamo a fare un video collegamento. Accade quando, magari, a turno, una delle mie sorelle, o mio fratello, vanno dai miei genitori per una rapida visita a misura di covid-19. Tutti i giorni si informano sui loro nipoti, comprese le mie figlie che vivono a quasi 900 km di distanza, preoccupandosi per loro proprio come facevano con noi da ragazzi in quei giorni così intensi del novembre 1980. Non si stancano mai di dire ai loro nipoti «non preoccupatevi, passerà anche questa, cerchiamo di stare attenti, passerà». Lo fanno sempre cercando di non fare trasparire le loro preoccupazioni per una Natura che, a volte, sembra quasi mostrare tratti di ostinazione, come se l’Umanità non facesse parte del grande Progetto che le appartiene.
Oggi non parliamo di «sciami sismici», ma di «ondate» e «curve di contagio». Non bisogna più scappare dalle case, ma starvi dentro in isolamento. Una telefonata o un messaggio ci notifica il contagio di un cugino, il ricovero di un altro, intanto che si scongiura il peggio.
Tutti noi ci troviamo a combattere contro un «ospite» indesiderato che si impadronisce del nostro corpo cercando di farne un po’ quello che gli pare. Uno degli aspetti peggiori di questo novembre, rispetto a quello di 40 anni fa, è che molto spesso potrebbe non esserci quella mano o quell’abbraccio del tuo caro mentre sei in pericolo o quando il il nostro «ospite» indesiderato riduce in fin di vita noi o un nostro caro. Quanto di più disumano potessimo immaginare.
Non so se «Dio gioca a dadi», ma so che se Tu vuoi giocare con le nostre vite, dall’altra parte del tavolo troverai l’Umanità che stai mettendo alla prova con la tua sfida mortale. Sarai anche scaltro, ma il Progetto dell’Umanità è quello della Vita, il tuo è un miserevole progetto di morte.
Leggi anche:
Come prepararsi al Natale 2020: le buone pratiche da seguire
De Luca sulla prossima riapertura delle scuole