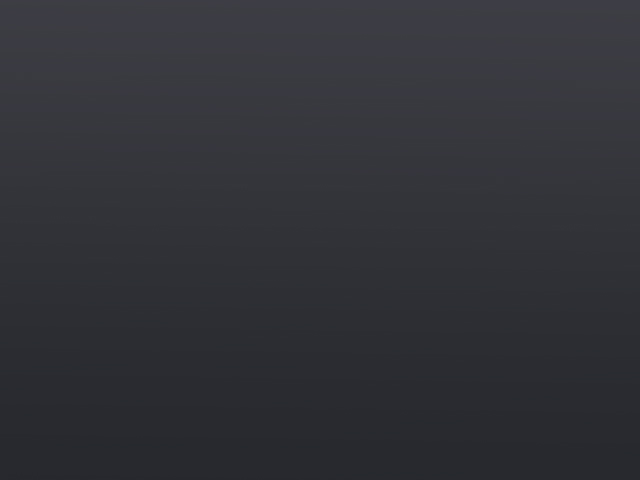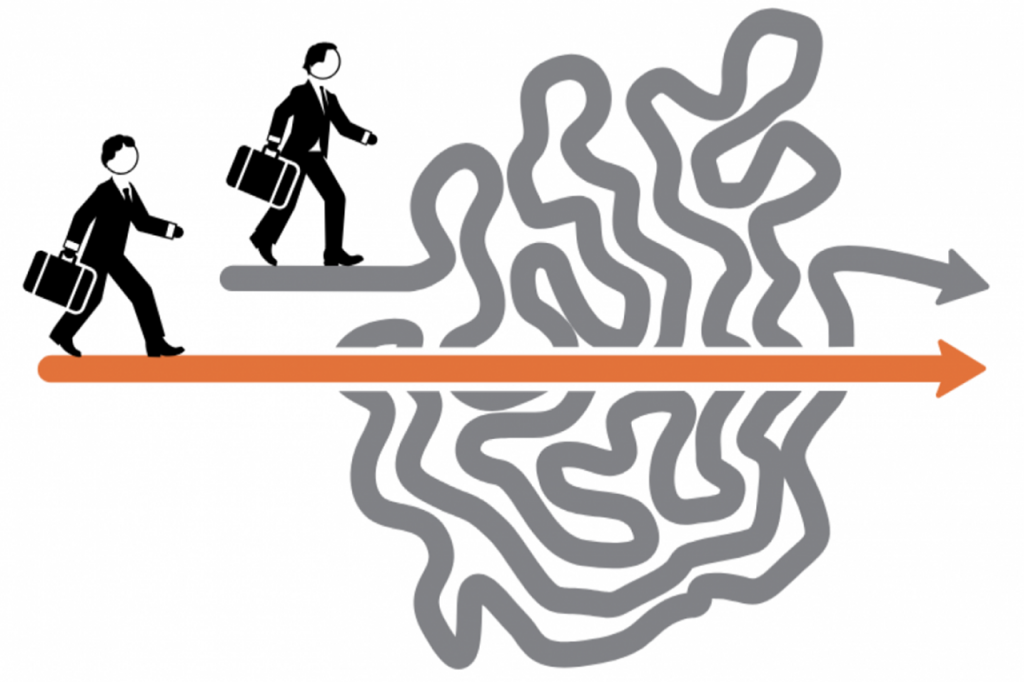In un mondo e in una realtà economica sempre più competitivi e globalizzati, il tema della responsabilità sociale delle imprese diventa una questione vitale per la sopravvivenza di un’organizzazione. Il mercato in cui le imprese oggi si trovano ad operare, infatti, risponde a idee e logiche molto diverse da quelle del secolo scorso: i profitti sono solo uno dei tanti fattori che un’organizzazione deve integrare nelle strategie aziendali, insieme alla dimensione etica e morale.
Il successo economico, quindi, non è più sufficiente. E ciò perché una situazione è vincente da un punto di vista economico quando lo è anche da un punto di vista ambientale e sociale, cioè quando è il risultato di una combinazione di fattori riguardanti interessi e attese che stanno a cuore alla totalità degli stakeholder.
Corporate Social Responsability: che cos’è
Il concetto di Corporate Social Responsability (responsabilità sociale d’impresa) nasce da un libro del 1953 scritto da Howard R. Bowen ed intitolato Social Responsabilities of the Businessman. L’autore afferma che centinaia dei più grandi businessmen negli Stati Uniti rappresentano enormi centri di potere e le azioni delle loro organizzazioni impattano su tutta la collettività. E quindi, che responsabilità hanno costoro? Il libro si riferisce agli obblighi degli uomini d’affari di perseguire determinate politiche, di prendere specifiche decisioni, o di seguire precise linee d’azione che siano desiderabili in termini di obiettivi e valori per la società.
Tale concetto si sviluppa nei contesti accademici a partire dal 1960, in cui prendono vita diversi framework di studio pubblicati da svariati autori, tra cui Keith Davis, Joseph McGuire, Adolph Berle, William Frederick e Clarence Walton. Il contesto storico e sociale in cui vengono pubblicati è quello della nascita dei movimenti sociali, come il movimento per i diritti civili, quello dei consumatori, i movimenti degli ambientalisti e delle donne. Esistono circa 37 definizioni di CSR, ma quella più fortunata è sicuramente quella di Carroll. Quest’ultimo individua 4 dimensioni o categorie di CSR che si strutturano secondo una forma piramidale.
“Corporate social responsabilities encompasses the economic, legal, ethical and discretionary (philanthropic) expectations that society has of organizations at a given point in time”.
La dimensione economica si focalizza sulla creazione di valore dell’organizzazione e la considera come l’unità economica di base di una società, da cui scaturiscono gran parte delle attività economico-sociali. Quella giuridica riguarda le aspettative sociali in termini di conformità legislativa. La dimensione etica rappresenta ciò che consente alle aziende di superare i limiti propri del diritto e fare in modo di orientare le proprie attività affinché acquistino correttezza, giustizia ed equità. La responsabilità etica, oltre ad essere una categoria ben distinta, permea ed influenza l’intera piramide. Considerazioni etiche sono presenti in tutti gli altri tipi di responsabilità.
Infine, la dimensione discrezionale o filantropica è legata alla possibilità che le aziende decidano liberamente quali attività etico-sociali svolgere. Il modello elaborato da Carroll rappresenta la base teorica su cui sono stati elaborati i framework successivi.
La CSR pone al centro della visione aziendale la volontà di comporre e coordinare i molteplici interessi dei diversi stakeholder che ruotano intorno all’azienda. Si mira a soddisfare in maniera crescente le attese sociali ed ambientali, legittime tanto quanto quelle economiche, dei differenti portatori di interesse interni ed esterni.
La CSR rimanda sostanzialmente alla capacità dell’organizzazione di garantire un’interconnessione completa e cioè un’identità di obiettivi tra economia, società e ambiente.
Un’organizzazione, dunque, è considerata sostenibile quando è stabile non solo dal punto di vista economico e finanziario, ma quando riduce al minimo il proprio impatto ambientale e integra le aspettative sociali, nel core business. La sostenibilità economica si riferisce alla capacità di un sistema economico di generare valore e una crescita duratura e cioè alla capacità di generare reddito e lavoro per il sostentamento delle popolazioni. La sostenibilità ambientale, invece, riguarda la minimizzazione degli impatti sugli ecosistemi che provocano una progressiva riduzione del patrimonio naturale e l’accettabilità dei rischi concernenti la salute umana. La sostenibilità sociale, infine, rappresenta la capacità di garantire equità nell’accesso ai beni e a condizioni di benessere.
Oltre ad orientare l’organizzazione verso l’integrazione di variabili di diversa natura, sono stati creati diversi strumenti e metodologie di rendicontazione e measurement. L’adozione di tali strumenti, che possono essere linee guida e standard gestionali, codici di condotta o veri e propri bilanci socio-ambientali, è principalmente volontaria, ma nonostante ciò sono sempre più utilizzati. Le imprese infatti hanno bisogno di fornire un quadro organico dei rapporti che esse intrattengono con l’intero panorama che le circonda, così da poter evidenziare gli impatti del proprio operato in relazione alle strategie implementate ed alle aspettative degli stakeholder. Si è infatti assistito al superamento del sistema contabile basato sulla bottom line a favore di una rendicontazione triple bottom line, capace di comunicare le performance ambientali, sociali ed economiche.
Comunicazione sostenibile e pinkwashing: il caso Primark
La comunicazione rappresenta una fase fondamentale del processo di CSR, in quanto permette di distinguersi dalla concorrenza, sviluppare e mantenere rapporti stabili e duraturi con gli stakeholder, rafforzare l’identità, i valori e la mission dentro e fuori l’impresa e creare reputazione e fiducia nel lungo periodo. Si tratta di un approccio globale che non riguarda solo la comunicazione tout court. La sostenibilità infatti è una strategia di sviluppo che gestisce tutti gli aspetti, le risorse naturali ed umane, così come gli aspetti fisici e finanziari, per l’incremento della ricchezza e del benessere nel lungo periodo.
Tuttavia esiste un delicato equilibrio tra la comunicazione di comportamenti effettivamente messi in atto e l’utilizzo di strumenti e iniziative comunicative a meri fini pubblicitari. Tra i numerosi rischi che si nascondono dietro i vantaggi derivanti dalla comunicazione sostenibile, spicca probabilmente quello del Greenwashing, cioè l’ingiustificata appropriazione di virtù ambientali da parte di un’azienda finalizzata alla creazione di un’immagine positiva di un’immagine mistificatoria per distogliere l’attenzione dalle responsabilità che l’azienda detiene nei confronti del rispetto dell’ambiente.
Oltre al greenwashing, si possono commettere errori legati al Pinkwashing. Questa parola è stata usata per la prima volta da un’associazione per la lotta contro il cancro al seno per identificare le aziende che fingevano di sostenere le persone malate di tumore. Sovente indica, in senso più ampio, il promuovere un prodotto o un ente, attraverso un atteggiamento di apertura nei confronti dell’emancipazione femminile o dei diritti delle persone omosessuali.
Uno dei casi più famosi di pinkwashing è quello messo in atto da Primark, il colosso irlandese della moda low cost che nella primavera del 2018 lanciò una collezione speciale chiamata “Pride”, ispirata all’attivismo LGBTQ+. L’azienda creò un’intera collezione destinata al mercato europeo e statunitense i cui proventi (per la precisione il 20%) sarebbe stati destinati a Stonewall, associazione britannica per i diritti LGBTQ+.
Ma dove ha sbagliato il management di Primark? Innanzitutto, i capi della collezione in questione erano stati prodotti in Turchia e in Myanmar, Paesi in cui i diritti delle persone LGBTQ+ sono a dir poco inesistenti. Inoltre, Stonewall, l’unica associazione che avrebbe beneficiato della donazione di Primark, non solo non era tra gli organizzatori dei Pride di quell’anno, ma aveva anche deciso di non partecipare al Pride di Londra di un paio di mesi prima. Primark, infatti, aveva scelto come destinatario della propria beneficenza un’unica associazione, anch’essa un brand grande e famoso, invece che supportare le associazioni locali che avevano materialmente organizzato i vari eventi in giro per l’Europa e che spesso soffrono una mancanza di fondi per finanziare le proprie iniziative. Una volta palesatosi l’intento commerciale, l’intera operazione perde molto del suo valore e fascino e appare semplicemente come una collaborazione tra due brand che traggono un beneficio reciproco dall’essere accostati l’uno accanto all’altro, in un momento di particolare visibilità per entrambi.
Le imprese che vogliono assumere un comportamento socialmente responsabile devono fare particolare attenzione al rischio che le proprie iniziative vengano accusate di essere solo un abbellimento dell’effettiva situazione. La comunicazione in tali casi non può essere intesa come uno strumento per giungere alla legittimazione sociale dell’impresa, ma dovrebbe focalizzarsi sullo stakeholder engagement, che implica invece l’assunzione di una posizione collaborativa nei confronti degli stakeholder al fine di ricercare un beneficio sia per l’impresa sia per gli stakeholder coinvolti.
Una presa di di decisioni discutibile
Da un punto di vista di etica del business il management di Primark, che ha pianificato l’iniziativa, può rientrare in un tipico caso di amoral management, per usare la terminologia di Carroll. Probabilmente, in tal caso, è mancata una prospettiva di lungo termine nelle decisioni prese dall’organizzazione e non si vedono delle reali conseguenze sull’ambiente in cui opera e intrattiene relazioni. Più precisamente, l’orientamento dei manager di Primark può essere un caso di ‘unintentional amoral decision, sempre per adottare la terminologia dell’autore dell’ideatore della piramide.
Legare una campagna ad una specifica causa può portare molta visibilità, ma bisogna porre attenzione su molteplici aspetti che in fase di progettazione potrebbero sembrare irrisori e poco importanti. Tuttavia, il rischio reputazionale è elevato ed un singolo passo falso potrebbe dissolvere anni di investimenti, diretti o indiretti, nella creazione di una buona reputazione.
In ottica di processi decisionali, probabilmente siamo di fronte ad un processo decisionale organizzativo basato sul modello Carniege. Secondo tale modello, le decisioni organizzative non vengono prese da un singolo decisore ma da una coalizione. Le coalizioni sono unioni temporanee di soggetti che condividono i medesimi obiettivi, la medesima percezione dei problemi e le stesse linee d’azione. I manager si impegnano nella ricerca per problemi, cioè esplorano l’ambiente circostante alla ricerca di una soluzione che risolva velocemente un problema, tuttavia i singoli manager possiedono limiti cognitivi ed altri vincoli e molto probabilmente, nel caso di Primark mancavano di un punto di vista differente.
Infatti, fare i conti con la diversità implica un percorso molto più complesso, destrutturato e destrutturante, legato alla trasformazione prima di tutto di sé stessi e del proprio modo di vedere il mondo. Accogliere le differenze, comprenderle e integrarle realmente nei valori aziendali, cosi l’iniziativa avrebbe senso, invece che plasmare a tavolino un’iniziativa svincolata e smaccatamente promozionale.
di Felice Trinchese, studente YLab for social and digital innovation
Leggi anche:
L’utilizzo di Netflix durante l’emergenza Covid-19
Il turismo e i processi decisionali del turista: dalle origini al web 2.0 e l’emergenza Covid-19